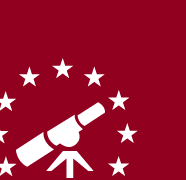Il metodo Vannoni e il peccato della Scienza
Il dibattito sulla cosiddetta “cura Vannoni” si fa sempre piu acceso in questi giorni e anche Prometeus ne ha estesamente parlato. Ogni volta che leggo le diverse opinioni sono però sempre più convinto che, ahimé, di questi episodi il nostro Paese sia destinato a vederne sempre di più negli anni a venire.
Faccio una premessa fondamentale, tanto per liberare subito il campo dalle ambiguità:
trovo assurdo che un laureato in lettere eserciti, o sovrintenda, una pratica medica, e ancora di più che tracci lo sviluppo di terapie nel campo delle biotecnologie cellulari e mediche. Trovo altrettanto assurdo che queste notizie emergano quando terapie non supportate da dati scientifici siano già state somministrate, e che non esista un controllo a priori. Ritengo deprimente il fatto che il Ministero della Salute prenda azioni sulla spinta del clamore di notizie, anziché esercitare quotidianamente il proprio compito di governance e di controllo pacato e scientifico.
Fatta questa doverosa premessa però, e chiarito che la pratica medica deve essere sempre scientificamente fondata, vorrei dire con altrettanta chiarezza che in questa vicenda mi sembra commettano tutti degli errori.
Da scienziato ho sempre creduto, e penso con ancora più convinzione leggendo queste notizie, che la maggior parte dei miei colleghi continui a fare un’equazione vecchia trent’anni e sempre difficile da cancellare:
la gente non sa nulla di scienza, reagisce emotivamente, e di conseguenza devo spiegare cosa è scientificamente giusto perché così la gente cambia opinione.
Questa equazione, che per chi se ne occupa si chiama “deficit model”, presuppone la convinzione che l’informazione sia data allo scopo di cambiare un comportamento. Per un sociologo, o per chi si occupa di public engagement, si tratta di concetti ormai polverosi, sentiti migliaia di volte, perfino ormai noiosi in ambito di ricerca del settore.
Ma il problema è che per la quasi totalità degli scienziati italiani, e purtroppo in molta parte della comunità scientifica in genere, questa convinzione è radicata profondamente, nonostante sia scientificamente tanto sbagliata quanto una terapia non basata su evidenze sperimentali.
La differenza non secondaria ovviamente è che la seconda gioca con la vita di qualcuno.
Ma nel comportamento sia i parenti dei pazienti che gli scienziati che si indignano per la cosa, e si prodigano in spiegazioni, in un certo senso commettono entrambi un errore.
Quello che mi interessa ancora di più in tutto questo, però, è capire come sia stato possibile, per l’ennesima volta, arrivare a questo punto.
Come mai ancora una volta leggiamo notizie, articoli, opinioni in cui la sceneggiatura è sempre simile:
qualcuno che “vende” speranze a chi ha disperatamente bisogno di speranza, pazienti o genitori che difendono il loro diritto a sperare, il pubblico che si divide, gli scienziati che si indignano e fanno la loro lezione sull’infondatezza e l’antiscientificità di certe pratiche, il Ministero nel panico che insegue vicende il cui passo corre molto più veloce dei tempi istituzionali, per non parlare di quelli legislativi.
Il motivo di questo fallimento della collettività deriva a mio avviso dall’arretratezza culturale e democratica del nostro paese nel rapporto tra scienza e società, e in particolare nella totale mancanza in Italia di pratiche partecipative. L’Italia è stata per anni fuori dalla rete dei Science Shops (di cui ora finalmente fanno parte ISPRA e Università di Sassari), ha avuto pochissime esperienze di public engagement e tranne poche eccezioni non ha certo svolto un ruolo chiave nel dibattito tra Scienza e Società in Europa.
Questa arretratezza, dell’Italia, delle sue Istituzioni e anche di molti suoi scienziati, ha un effetto cruciale nella gestione delle “fratture” causate dalle innovazioni scientifiche, o dalle promesse di innovazioni, e le esigenze di attori sociali o parti interessate.
Già nel 2009 la Commissione Europea osservava che:
“The governance of scientific institutions is under pressure, not least because of different contexts of governance, simultaneously pushing innovation, democratization and scientific integrity. […] The challenge is to support ongoing dynamics, rather than containing them, so dynamic governance is called for”.
Nell’ultimo rapporto sullo stato delle iniziative di scienza e società vengono sottolineati due concetti chiave: da un lato l’eterogeneità dei vari paesi europei e la cultura politica non inclusiva che costituiscono una barriera ad un governo più democratico e inclusivo della scienza, dall’altro significative differenze nell’uso della conoscenza scientifica nei processi decisionali.
Provate ad indovinare dove si trova l’Italia.
Ecco, io credo che il motivo fondamentale per cui da noi si ripeta costantemente il copione che è andato nuovamente in scena con la vicenda Vannoni è che il nostro Paese non è democraticamente preparato a gestire in modo partecipativo e condiviso le innovazioni scientifiche.
I nostri scienziati non sono culturalmente attrezzati a considerare le aspettative, i desideri e le emozioni al pari delle argomentazioni scientifiche, anche se con un ruolo ovviamente differente. I cittadini stessi non sono abituati a gestire un ruolo decisionale, quando gli viene data voce. Le nostre istituzioni non hanno alcuno strumento inclusivo per giungere a decisioni condivise e, proprio perché tali, capaci di penetrare la società profondamente e con tutte le argomentazioni, non solo scientifiche, che solo un processo di governance partecipativa può generare.
Io credo che, se in Italia ci fosse più abitudine a discutere in anticipo le evoluzioni della scienza, e decidere assieme ai gruppi di pazienti, agli attori sociali interessati, ai tanti portatori di sensibilità e interessi diversi, assieme ai ricercatori coinvolti, dove destinare le risorse della ricerca scientifica, dell’innovazione sanitaria, dei protocolli di cura, non saremmo arrivati ad un nuovo caso “cura Vannoni” alla stregua di quanto avvento per la “cura Di Bella”.
In questo purtroppo non penso siano il Ministero, o i promotori di terapie più o meno eccentriche e scientificamente fondate, ad avere la responsabilità principale, ma che siamo proprio noi scienziati a giocare un ruolo chiave.
Anziché soltanto spiegare, o tentare di convincere, forse dovremmo ascoltare un po’ di più le speranze e le emozioni di chi non vede le cose coi nostri occhi, saper dialogare, e comprendere che nella nostra stessa quotidianità l’informazione oggettiva è solo una parte delle cose che anche noi prendiamo in considerazione per decidere.
Che lo vogliamo o no, vale anche per la scienza e per la medicina, ed è anche per questo che il nostro ruolo è ancora più importante.
Quanto alle istituzioni del nostro Paese, forse sarebbe il caso che si attrezzassero finalmente, senza inventare l’acqua calda, ma prendendo esempio dagli altri.
La Danimarca, che da oltre vent’anni sperimenta e dà l’esempio su decisioni partecipative, si è dotata del “Danish Board of Technology”, una istituzione ormai famosissima e dedicata esclusivamente a studiare, sviluppare e mettere in pratica processi decisionali inclusivi.
Se anche l’Italia avesse strumenti simili, se ogni Università avesse un Science Shop, e Comuni, Regioni e Ministeri usassero pratiche partecipative, forse avremmo qualche investimento in più in ricerche meno ortodosse, ma avremmo anche, credo, meno parlamentari convinti che le vaccinazioni facciano male.
Francesco Lescai – @tokybo