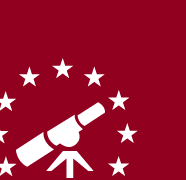Do iu spic ing-lisc?
È di un paio di giorni fa la notizia della conclusione, con sentenza del TAR, del tentativo, non riuscito, del Politecnico di Milano di rendere obbligatoria la lingua inglese per tutte le lauree magistrali dell’Ateneo.
Già un anno fa, quando si era aperta la polemica per questa scelta del Senato Accademico cui numerosi professori si erano opposti con forza, un solerte deputato del PD (Marco Beltrandi) aveva presentato una interrogazione parlamentare in cui definiva “il sistema d’insegnamento italiano alle soglie della completa colonizzazione anglofona” e affermava come “l’insegnamento nella lingua madre sia di qualità superiore di quello impartito in una lingua diversa” sostenendo l’iniziativa del Ministero a promuovere l’uso dell’Esperanto per l’internazionalizzazione dei corsi.
Il TAR ha dunque bocciato quel provvedimento, accogliendo il ricorso di 150 docenti, affermando che i corsi erogati in inglese
non favoriscono l’internazionalizzazione dell’ateneo, ma ne indirizzano la didattica verso una particolare lingua e verso i valori culturali di cui quella lingua è portatrice .
La prima reazione ovviamente è di scoramento, per la miopia con cui in Italia si ascolta sempre una sola campana, solitamente la più provinciale, senza confrontarsi con quello che accade (perlomeno) nel resto d’Europa. Poi ci si fanno delle domande.
Innanzitutto, se il desiderio di erogare tutte le magistrali in inglese sia o meno genuino e dovuto ad una reale scelta di competitività sul piano internazionale, oppure se esistano – come purtroppo accade spesso – anche degli interessi differenti.
La normativa italiana consente ai corsi erogati in inglese numerose deroghe nei regolamenti didattici di ateneo: alle attività formative di base e caratterizzanti (si può assegnare un numero diverso di CFU), al numero di esami, alla durata, alla numerosità minima degli studenti, ai limiti alla contribuzione studentesca.
Mi sembra naturale quindi rilevare che l’istituzione di corsi internazionali possa rendere un Ateneo meno vincolato sia in termini di definizione dei corsi, sia purtroppo in termini di diritto allo studio.
La seconda domanda è sul perché tutti questi docenti si oppongano con tutta questa forza. È vero che il provvedimento del Politecnico non opera alcuna distinzione fra discipline, e questo sicuramente impone vincoli in aree disciplinari più strettamente correlate alla lingua che forse avrebbero potuto essere affrontate diversamente dall’Ateneo. Viene però altrettanto naturale pensare che molti docenti, e lo sappiamo per nostra esperienza personale, non abbiano alcuna intenzione di insegnare in inglese. Alcuni, senza generalizzare s’intende, forse non ne sono neanche in grado. D’altra parte un più generalizzato insegnamento universitario erogato in inglese offre maggiori opportunità di confronto e comparazione con altri corsi in Europa. E i nostri docenti lo vogliono? Siamo davvero sicuri che la docenza universitaria italiana, che ha la media di età più alta del continente, abbia veramente voglia di confrontarsi alla pari sul proprio modo di fare didattica?
Confrontarsi con gli altri sulla ricerca è difficile, ma fa parte da sempre del concetto di ricerca stessa. Il problema vero in Italia è sempre stato quello della valutazione, non quello della produzione. Introdurre lo stesso concetto anche nella didattica ha un effetto dirompente: lega molto di più didattica e ricerca – argomento tanto caro alle Università non a caso in cima alle classifiche internazionali (“research-led teaching”) – e apre l’insegnamento ad una competizione e valutazione mai esistita prima nel nostro paese.
Non mi risulta che a nessun docente universitario (tanto meno negli ultimi requisiti di abilitazione nazionale) sia richiesto il cosiddetto “teaching portfolio”, fortemente in uso nelle Università del nord Europa.
Del resto questo dibattito nasce in uno scenario dove solitamente i giovani ricercatori sono obbligati ad insegnare, ma preferiscono fare ricerca, e chi ha smesso di fare ricerca spesso fa fin troppe lezioni: anche questo ben noto a tutti noi che siamo stati studenti.
L’ultima e meno folkloristica domanda che mi pongo riguarda però il desiderio dell’Italia di portare davvero le proprie Università sulla scena internazionale, di renderle competitive soprattutto nell’attrarre studenti e docenti da altri paesi Europei. È sempre lo stesso problema fin troppo poco dibattuto quando parliamo di fuga dei cervelli: che i ricercatori facciano esperienze in altri paesi non sarebbe un problema se la bilancia di import/export fosse comunque positiva.
Mentre il 67% degli atenei europei offre sempre più corsi in inglese , l’Italia ha una offerta formativa in inglese molto bassa: 191 programmi nel 2011 contro gli 812 dell’Olanda, i 632 della Germania e i 401 della Svizzera .
Proporzioni ancora più sorprendenti se dovessimo pesarle sulla popolazione dei rispettivi paesi. E questo si riflette inevitabilmente sull’attrattività degli studenti per l’intera durata di un corso. I dati a disposizione non ci aiutano, perché sono soprattutto disponibili per l’Erasmus, dove l’Italia gioca ancora un fortissimo appeal per la ben nota qualità della vita, però sono comunque significativi:
-
Da noi viene a studiare un numero di studenti stranieri pari all’84.6% degli studenti Italiani che vanno all’estero.
-
La Spagna, che è il primo paese per mobilità Erasmus, importa il 97.3% di quanti studenti spagnoli vanno all’estero.
-
Per l’Inghilterra le proporzioni sono incredibilmente invertite: vanno a studiare in UK il 204% di quanti studenti inglesi vanno nel resto d’Europa .
Non ci piazziamo bene neanche sulle classifiche del nostro staff inviato all’estero per esperienze di mobilità, contrariamente a Spagna, Germania e Francia.
Mi pare quindi, nonostante il tentativo più razionale di analisi, di dover tornare alla mia reazione iniziale: come sempre in Italia non si vedono mai gli scenari globali, e si discute di questi problemi in modo molto miope, chiamando in causa termini importanti come “cultura”, “colonizzazione”, “valori” che non hanno nulla a che vedere con il problema. Il sospetto è che sia il solito vecchio modo per non esporsi al confronto e alla competizione, per la paura di essere valutati, e di far sapere agli altri che a parte per il sole e il mare il sistema ricerca dell’Italia non è in grado di reggere il confronto internazionale.
Sarà forse per lo stesso motivo che tanta gente ha scelto di lavorare in una Università straniera. Me compreso.